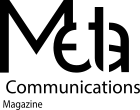- Home
- Interviste
- Massimo De Vittorio e la silen ...

È uno splendido maggio nel Salento. Qui la primavera riesce a mandare in visibilio, con una velocità impressionante, i neuroni di chi vi si trova, o anche è solo di passaggio, ampliando una sensazione cerebrale di espansione del benessere che ha ottime ricadute su qualunque cosa si stia facendo. Questo territorio (è noto) è anche causa di proliferazione di grandi cervelli, che per fortuna non fuggono spesso, ma che fanno in modo da sedimentare quelle scintille di innovazione che poi vanno ad incendiare linee progettuali di ricerca in tutto il mondo. Alcune di queste scintille sono quelle prodotte da Massimo De Vittorio. Non starò qui ad elencare la sfilza di titoli e scoperte che lo caratterizzano, perché basta nominare Istituto Italiano di Tecnologia, Università del Salento e Università Tecnica della Danimarca per dare solo un piccolo imprinting di ciò che ha fatto e soprattutto che sta facendo. Quando lo incontro via call per l’intervista si trova a Copenaghen per dirigere un importante gruppo di ricerca. E la prima cosa che mi dice, con lo sguardo felice, è che si sente uno studente fuori sede. Bella sensazione penso. In realtà questa leggerezza nasconde un impegno molto importante che dovrebbe far capire ben presto la linea delle nuove frontiere della medicina che insieme alle ultime tecnologie daranno una vera svolta al modo in cui noi tutti percepiamo la salute. Questa intervista è improntata sulla dimensione (per fortuna in continua crescita) di quelle che sono le tecnologie indossabili, impiantabili e anche ingeribili e che nei prossimi anni cambieranno il rapporto che abbiamo con il nostro corpo. Massimo accoglie le mie domande con un sorriso mentre si accomoda sulla poltrona dell’ufficio danese, pronto a condividere la sua visione di una medicina del domani che è già, in parte, presente.
Partiamo dalle basi. Parliamo di quel “gap” che è insito al momento nel processo tradizionale di guarigione?
Nella medicina classica abbiamo un percorso apparentemente lineare, diagnosi, analisi dei dati da parte del clinico, terapia e, si spera, guarigione. Ma qui, in questo punto del cerchio che unisce le varie fasi, ci sono un sacco di problemi. Il problema principale siamo, prima di tutto, noi stessi. Mentre abbiamo una grande capacità di capire cosa ci circonda attraverso i nostri sensi – vista, tatto, udito, gusto e odorato – non conosciamo quasi per nulla quello che sta accadendo all’interno del nostro corpo. Abbiamo dei recettori che sono scarsamente in grado di dirci che qualcosa sta andando male, come i recettori del dolore, che anche se avvertiamo, spesso non sappiamo dove questo dolore sia effettivamente ben localizzato, e molte volte non conosciamo la motivazione del dolore. Il corpo ci dà un’idea vaga di quello che sta succedendo, e questo può far sì che talvolta non riusciamo proprio a sentire i sintomi di qualcosa che sta andando storto.
È come se mancasse una cultura della percezione interna del nostro corpo?
Esattamente. Mancano proprio i mezzi diagnostici giusti che le persone possono utilizzare. Il medico, d’altra parte, si basa sulla sua cultura medica, su quello che ha studiato e sulla sua esperienza. Questa può essere sufficiente nel 90% dei casi, ma puoi avere anche il caso completamente sconosciuto al medico stesso e che quindi non è in grado di interpretare, o talvolta può succedere che la diagnosi non sia corretta. Di conseguenza, può succedere che venga data al paziente una terapia non corretta e non personalizzata per la persona specifica. Tutto questo porta ad un recupero che non è immediato; anzi, la malattia magari migliora solo parzialmente, ma il cerchio della guarigione non si chiude, e il paziente allora deve tornare indietro per un’altra diagnosi e altri esami. Questo loop ciclico, quando va bene termina abbastanza in fretta, ma quando va male non si chiude proprio.
Come si può allora interrompere questo ciclo problematico?
Quello che noi sviluppiamo come filosofia e come tecnologie, è il cercare di produrre sensori che aiutino noi stessi, e quindi anche il medico e il sistema sanitario, ad individuare in modo molto precoce determinati sintomi. Questi dispositivi possono trovarsi sul o nel corpo, fuori dal corpo o attaccati ad esso, possono essere cerottini, sensori indossabili integrati in una maglietta, in orologi, oppure tecnologie impiantabili all’interno del corpo.
Puoi fare qualche esempio concreto di queste tecnologie impiantabili?
Certo. Ci sono dispositivi all’interno del cervello studiati ad esempio per il Parkinson che hanno sensori che rilevano quando c’è un’anomalia e producono nel momento in cui occorre, un’azione per stimolare l’attività neurale. O anche per il cuore, come il defibrillatore impiantabile. Quindi c’è la parte di sensore, che è il dispositivo che sente che qualcosa sta andando male, e l’attuatore, che una volta che il dato del sensore viene analizzato e risulta anomalo, genera un alert ed ha il compito di far ripartire il cuore, oppure di bloccare o attivare l’attività dei neuroni.
Quindi fai una distinzione tra diverse tipologie di tecnologie. Esiste allora una classificazione di queste?
Certamente. Chiamiamo ‘tecnologie invasive’ quelle dentro il corpo umano. Poi abbiamo le ‘tecnologie non invasive’, che sono quelle fuori dal corpo, che possono anche essere ‘non intrusive’ perché ti permettono di agire e comportarti come se non le avessi addosso, non te ne accorgi. Infine, c’è una terza tipologia di tecnologie per il corpo umano, e sono quelle che si muovono all’interno di noi stessi, come per esempio le pillole elettroniche, che sono temporaneamente all’interno, perché vengono ingerite ma, dopo aver attraversato il sistema gastrointestinale, vengono espulse o in altri casi, riassorbite. Queste tre tipologie di dispositivi sono quelle su cui io lavoro.
Qual è allora, la differenza fondamentale tra la diagnosi tradizionale e questa nuova visione della medicina?
L’idea è che rispetto alla diagnosi tradizionale, dove hai la misura e l’analisi una tantum, la nuova medicina ha bisogno di monitorare il tuo corpo continuamente – ogni secondo, ogni minuto, anche ogni ora – raccogliendo dati da confrontare poi con quelli precedenti. Alla fine, riesci a scoprire se c’è un’anomalia. In condizioni normali i miei dati sono costanti nel tempo, ma se a un certo punto c’è una variazione devo approfondire. Cosa è successo? È una variazione positiva perché sto facendo più attività fisica o mi sto alimentando meglio? Oppure, se mi sto comportando nello stesso identico modo, è negativa perché c’è qualcosa che è cambiato all’interno del mio organismo?
Quindi è un approccio preventivo più che reattivo…
Sì, anche se non sappiamo esattamente quello che sta succedendo dentro di noi, già questo è un alert che dice: ‘Ok, io mi sento normale, però c’è qualcosa che sta cambiando, quindi fammi andare a controllare, fammi andare a vedere se ci sono degli aspetti che devo approfondire a livello cardiovascolare, cerebrale, eccetera’. Quindi monitorare per intercettare delle anomalie in modo molto precoce.
Questi dati personali sembrano avere un valore enorme. Cosa succede una volta raccolti?
Una volta che hai questi dispositivi elettronici sul corpo o all’interno, i dati vengono raccolti su di te come su altre decine di migliaia, centinaia di milioni di persone. Grazie ai big data e all’intelligenza artificiale, alla raccolta e all’analisi di questi dati da parte dei giganti tecnologici come Samsung, Google, Apple, Amazon, si possono identificare pattern significativi. Se tu aggiorni la tua cartella clinica indicando che hai sviluppato una patologia, diciamo il Parkinson, loro possono andare a vedere se altre persone che hanno sviluppato il Parkinson hanno dei pattern di dati simili al tuo. Possono andare a ritroso analizzando tutta la tua storia. In questo modo si potrà quindi ipotizzare se c’è la possibilità di sviluppare una determinata patologia in modo precoce se quello stesso pattern di dati si ripresenterà in altre persone in futuro.
Sembra quasi che si stia creando una sorta di “biografia medica digitale” di ciascuno di noi. È così?
Idealmente, uno dovrebbe riuscire ad ottenere una fotografia dinamica del nostro stato di salute dalla nascita. Alla nascita puoi verificare il patrimonio genetico, poi però nel tempo il patrimonio genetico evolve. Ognuno di noi parte da una base genetica, ma poi idealmente si dovrebbero raccogliere dati sullo stato di salute in modo continuativo. Si sta lavorando molto per costruire una cartella clinica storica che sia sempre disponibile, ma non esiste ancora in modo strutturato. Poi ci sono i temi della privacy e della gestione dei dati, che sono oro puro per il loro valore per molte aziende operanti nel campo della salute.
A cosa servono concretamente questi dati oltre alla diagnosi precoce?
Questi dati sono utilissimi anche per la progettazione di sensori utilizzabili per fare screening di farmaci, cioè per verificare che la terapia effettivamente stia funzionando. Idealmente i giganti tecnologici dovrebbero dare l’accesso dei loro dati sanitari al sistema sanitario nazionale – essendo un patrimonio strategico per ogni singolo paese. Ed i dati devono ovviamente essere anonimizzati in modo che solo il medico personale possa riuscire ad agganciare il dato con la persona.
C’è qualcosa che ti preoccupa in questa visione del futuro della medicina?
Diciamo che la privacy è una di queste, come ho accennato. Ma c’è anche il rischio di creare disparità nell’accesso a queste tecnologie. Non tutti possono permettersi dispositivi all’avanguardia, e questo potrebbe amplificare le disuguaglianze sanitarie esistenti. Inoltre, c’è la questione dell’interpretazione dei dati – avere più dati non significa automaticamente avere diagnosi migliori se non abbiamo gli strumenti per interpretarli correttamente. Ma sono convinto che i benefici potenziali superino di gran lunga questi rischi, se gestiti adeguatamente. Il resto lo farà la buona ricerca.
Dopo aver salutato Massimo De Vittorio mi soffermo un attimo a riflettere su tutto quello che mi ha detto e mi rendo conto che quella che sembrava fantascienza solo dieci anni fa oggi è realtà nei laboratori dell’IIT. La medicina del domani è già qui, potremmo dire a mò di slogan, e sta silenziosamente trasformando il rapporto che abbiamo con il nostro corpo e con la nostra salute.